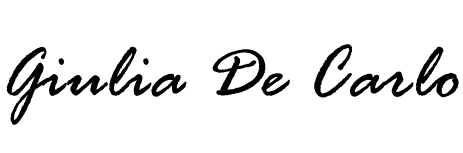I sogni premonitori e la saggezza inconscia: sogni come protettori dai pericoli
Sin dall’antichità, l’idea che i sogni potessero contenere informazioni sul futuro ha affascinato l’essere umano, suscitando interrogativi e interesse in ogni epoca e cultura. Il fenomeno dei sogni premonitori è stato osservato e documentato fin dai tempi delle civiltà mesopotamiche e greche, dove il sogno era considerato un canale privilegiato per ricevere messaggi divini o intuizioni provenienti da una dimensione trascendente (Artemidoro di Daldi, Oneirocritica, II sec. D.C.; Meier, 1987). Nell’esperienza moderna, i sogni premonitori si rivelano spesso solo a posteriori, ossia quando, alla luce di un evento accaduto, ci rendiamo conto di averlo in qualche modo anticipato oniricamente. Questa dinamica suggerisce che non si tratti di eventi necessariamente rari, ma piuttosto di contenuti che il nostro stato di coscienza ordinario tende a non riconoscere o a sottovalutare nel momento in cui emergono. Prestare attenzione a sogni che ci mettono in guardia – come immagini di pericolo imminente o situazioni catastrofiche – può avere un valore preventivo. In quest’ottica, il sogno si configura come uno strumento di protezione e orientamento. Secondo la prospettiva dell’analisi junghiana, ogni individuo possiede un nucleo di saggezza inconscia, che si manifesta simbolicamente nei sogni e che si pone al servizio della totalità e della sopravvivenza psichica e fisica del soggetto (Jung, 1964). Tale funzione anticipatoria del sogno, che Jung definisce “prospettica”, non implica necessariamente una previsione deterministica degli eventi, ma piuttosto un’intuizione profonda della direzione in cui si sta muovendo la vita del soggetto, e delle possibili conseguenze inconsce delle sue scelte (von Franz, 1980). In questo senso, il sogno premonitore può essere compreso come una manifestazione autonoma dell’inconscio che segnala squilibri, opportunità o minacce ancora non percepite dalla coscienza. L’ascolto di questi messaggi può rappresentare un potente strumento per comprendere ciò che accade intorno a noi e prendere delle decisioni di conseguenza, anche se non sempre è facile distinguere se sono le nostre paure a farci sognare delle cose oppure ci giungono messaggi dall’inconscio per metterci in guardia. Per riuscire a fare delle discriminazioni è necessario avere una certa dimestichezza con il mondo onirico. Una dimostrazione della funzione dei sogni come segnali di pericolo fu testimoniata da C. G. Jung in due casi che lui seguì. Nonostante il suo intervento i pazienti non compresero il pericolo in cui stavano incorrendo e purtroppo non ascoltarono il terapeuta. Si tratta di un uomo che, ignorando l’avvertimento onirico pagò con la vita la sua indifferenza e una donna che venne brutalmente aggredita. Afferma Jung che la funzione generale dei sogni consiste nel restaurare il nostro normale status psicologico. Infatti la produzione di materiale onirico serve a stabilire un certo equilibrio psichico. Questo è ciò che Jung definisce la funzione complementare (o compensatorio) dei sogni nell’ambito della naturale forma mentis psichica. Questa ipotesi spiega alcuni fenomeni come per esempio perché le persone che hanno idee non realistiche o una troppo alta opinione sul proprio conto, o che fanno progetti grandiosi del tutto sproporzionati alle loro effettive capacità, sognano di volare o di cadere. In questi casi i sogni compensano le carenze narcisistiche della loro personalità e contemporaneamente mette in guardia queste persone contro i pericoli del loro comportamento. Afferma Jung che se gli avvertimenti dei sogni non vengono presi in considerazione, possono accadere veri e propri incidenti. Un caso di questo tipo fu documentato da Jung. Si trattava di un uomo che era immerso fino ai capelli in un gran numero di affari poco puliti. Egli maturò una passione pressoché morbosa per le rischiose scalate alpinistiche, come una specie di compensazione, probabilmente quel gesto era il tentativo «di superare se stesso». Una notte sognò di precipitare nel vuoto dalla sommità di un’alta montagna. Quando raccontò il sogno a Jung, il terapeuta comprese il grave pericolo cui andava incontro e cercò di fargli capire l’avvertimento del sogno persuadendolo a contenersi. Gli disse che il sogno prediceva la sua morte in un incidente alpinistico. Tutto fu invano. Sei mesi dopo egli «precipitò nel vuoto». Una guida di montagna lo osservava mentre, insieme a un amico, si stava calando con la corda in un tratto difficile. L’amico aveva trovato un appiglio provvisorio su una sporgenza della parete e il paziente di Jung lo seguiva. Improvvisamente, secondo il racconto della guida, egli si staccò dalla corda «come se saltasse nel vuoto». Cadde addosso all’amico e precipitarono insieme. Tutti e due morirono. Un altro caso dello stesso tipo riguardava una signora che aveva un gran concetto di sé. Nella vita di tutti i giorni era molto orgogliosa, ma faceva sogni impressionanti che le portavano alla mente ogni sorta di cose disgustose. La signora non voleva ammettere di avere questi pensieri a Jung, ma nei sogni questi movimenti inconsci si manifestavano segnalando dei desideri inconfessabili legati a sensi di colpa e vergogna. Jung cercò di portare alla coscienza della signora i suoi pensieri ma lei si rifiutò di riconoscerli. Questa resistenza alimentò l’emersione di sogni minacciosi e pieni di riferimenti alle passeggiate che essa era solita fare tutta sola nei boschi, dove si abbandonava a fantasie sentimentali. Jung compresi il pericolo cui lei andava incontro, ma essa non volle prestare ascolto ai suoi ripetuti avvertimenti. Poco tempo dopo venne selvaggiamente aggredita in un bosco da un pervertito sessuale e, se non fosse stato per l’intervento di alcune persone che avevano udito le sue grida, sarebbe stata uccisa. Sottolinea la moderna psicologia che in questi fenomeni non c’è nulla di magico. Dai sogni della signora trapelava il suo desiderio di vivere una avventura erotica nelle sue passeggiate ma questa fantasia nel momento in cui non era stata riconosciuta aveva posto le premesse per metterla in pericolo. Lo stesso tipo di stato mentale in cui si era posto il paziente di Jung nel desiderio di risolvere i suoi problemi. Jung interpretò la morte del suo paziente scalatore come la ricerca di un modo definitivo di risolvere le sue difficoltà. Ovviamente, nessuno dei due si aspettava di dover pagare un prezzo così duro; la signora si ritrovò con varie ossa fratturate e lo scalatore perdette la vita. Vediamo da questi esempi che talvolta i sogni possono annunciare certe situazioni molto tempo prima che esse si verifichino. Non si tratta necessariamente né di un miracolo né di una forma di prescienza ma crisi delle modalità tipiche dei meccanismi di difesa; che ad un certo punto mostrano di essere disfunzionali e pericolosi. Infatti in entrambi i due casi i pazienti mostrarono come erano soliti usare la negazione per affrontare degli aspetti legati alla loro vita. L’uso massiccio di questo meccanismo non permise ad entrambi di tenere in considerazione il reale pericolo in cui si stavano mettendo. Sottolinea Jung che questo tipo di crisi di solito comincia molto tempo prima dell’incontro con il terapeuta e ha una lunga storia inconscia che risale alle prime relazioni parentali. L’individuo poi avanza nella vita del tutto inconsapevole dei rischi in cui incorre, e dei pericoli che si vanno ad accumulare a causa del perpetuarsi di certe modalità. In queste condizioni spesso ciò che non si riesce a vedere consciamente perviene alla coscienza dall’inconscio, che può trasmettere l’informazione attraverso i sogni. L’uso dei sogni come guide e indicatori della direzione da intraprendere nell’esistenza ha influenzato gli esseri umani in tutte le epoche. Vediamo che in diverse culture vennero documentati sogni che prevedevano situazioni e rituali per accedere al mondo dell’invisibile per ottenere indicazioni da questa dimensione.
I sogni premonitori nell’antichità: tra divinazione, medicina e filosofia
Nell’antichità si dava molta importanza ai sogni ed erano considerati strumenti legittimi per comprendere il futuro, anche se il loro significato variava secondo il contesto: divino per i mesopotamici, terapeutico per i greci, filosofico e politico per i romani. Questa molteplicità di significati testimoniava il valore simbolico e universale del sogno come ponte tra la psiche umana e le forze misteriose che governavano l’esistenza. Vediamo come nel corso della storia umana, i sogni sono stati considerati uno dei principali strumenti per accedere a dimensioni invisibili della realtà. Tra questi, i sogni premonitori – ossia quelli che sembrano anticipare eventi futuri – hanno avuto un ruolo centrale in molte culture antiche, assumendo un significato religioso, simbolico e terapeutico. La loro interpretazione, nota come oniromanzia, era parte integrante della vita sociale, politica e spirituale. Nella Mesopotamia, culla delle prime civiltà urbane, i sogni erano ritenuti veri e propri messaggi degli dèi. Le tavolette cuneiformi di Ninive, note come Iskar Zaqiqu, rappresentano uno dei primi trattati sistematici sull’interpretazione dei sogni. Questi documenti, databili al secondo millennio a.C., descrivono sogni premonitori legati a eventi pubblici, guerre o disastri naturali (Saggia Sibilla, s.d.). Anche nella Grecia arcaica i sogni erano considerati messaggi divini, ma con un’enfasi particolare sulla dimensione ctonia, legata al mondo infero e all’anima. La pratica dell’incubatio, che consisteva nel dormire in un santuario per ricevere un sogno rivelatore, era diffusa in luoghi come Epidauro, dedicato al dio Asclepio. In epoca ellenistica, Artemidoro di Daldi compose l’Oneirocritica, un’opera fondamentale per la storia dell’oniromanzia, nella quale i sogni vengono analizzati tenendo conto della condizione individuale del sognatore (Artemidoro, Oneirocritica, II sec. d.C.). Numerosi episodi storici confermano l’importanza attribuita ai sogni: Alessandro Magno, ad esempio, consultava il suo indovino Aristandro di Telmeso, il quale interpretava sogni che influenzavano decisioni strategiche durante le campagne militari (Significato Sogni, s.d.). Nella Roma antica, l’approccio ai sogni era più razionalista. Autori come Cicerone ne criticavano il valore predittivo, considerandoli frutto di superstizione. Nella sua opera De divinatione, Cicerone mette in discussione la possibilità che i sogni possano realmente predire il futuro. Tuttavia, nonostante il diffuso scetticismo, alcuni eventi storici – come il sogno premonitore di Calpurnia, moglie di Giulio Cesare, prima della sua uccisione – continuarono ad alimentare la credenza nella loro validità (Tribunus, 2022; Saggia Sibilla, s.d.). Anche la medicina antica riconosceva ai sogni un ruolo importante. Nella scuola di Ippocrate, essi venivano utilizzati per diagnosticare squilibri corporei, partendo dal presupposto che l’anima potesse percepire segnali che sfuggono alla coscienza vigile. Galeno, medico romano, distingue tra sogni provocati da cause fisiologiche e quelli che derivano da stati psichici profondi. Aristotele, invece, nei suoi trattati De Insomniis e De Divinatione per Somnum, propone una spiegazione naturalistica del sogno, pur riconoscendone talvolta un valore anticipatorio (Treccani, s.d.).
Conclusione: I sogni premonitori rappresentano una bussola per l’esistenza
I sogni premonitori, lungi dall’essere meri frammenti fantastici della notte, si configurano come messaggi profondi provenienti dalle parti più oscure e sapienti della psiche. Le testimonianze storiche e cliniche mostrano come essi possano svolgere una funzione protettiva, anticipando eventi critici o segnalando squilibri interiori prima che si manifestino nella realtà concreta. In questo senso, il sogno diviene non solo specchio dell’anima, ma anche bussola dell’esistenza, capace di orientare il soggetto verso una maggiore integrazione e consapevolezza di sé. La prospettiva junghiana evidenzia come l’inconscio non sia solo un deposito di contenuti rimossi, ma una fonte di guida e trasformazione, che attraverso simboli e immagini tenta di compensare gli eccessi della coscienza e di ripristinare un equilibrio perduto. I sogni che ci mettono in guardia non sono semplici allucinazioni notturne, ma strumenti evolutivi dell’anima, che invitano ad ascoltare la voce silenziosa del profondo. Saperli accogliere, interpretare e integrare nella vita quotidiana è un’arte delicata, ma fondamentale per il percorso di individuazione e per la salvaguardia del benessere psicologico e spirituale.
Bibliografia
Artemidoro di Daldi. (s.d.). L’interpretazione dei sogni.
AA.VV. (2005). Antiche vie all’eternità. Colloquium internazionale sugli aspetti dell’ascesi nei primi secoli del cristianesimo.
AA.VV. (2009). Problemi di storia religiosa nel mondo tardo antico.
Canetti, L. (2010). L’incubazione cristiana tra Antichità e Medioevo. Rivista di Storia del Cristianesimo, 7, 149–180.
Canetti, L. (2012°). La visione di Costantino e la storia culturale dei sogni. Storica, 54, 7–43.
Canetti, L. (2012b). Commonitus in quiete: la visione di Costantino tra oracoli e incubazione. In Costantino, el primer emperador cristiano? Religión y política en el siglo IV (pp. 71–88).
Cavini, W. (2009). Fantasma. L’immagine onirica come apparenza illusoria nel pensiero greco del sogno. Medicina nei Secoli, 21(3), 737–772.
Cicerone. (ca. 44 a.C.). De divinatione.
Cox Miller, P. (2003). Il sogno nella tarda antichità.
Galeno. (ca. II sec. D.C.). De dignotione ex insomniis.
Guidorizzi, G. (2013). Il compagno dell’anima: i Greci e il sogno. Milano: Rizzoli.
Guidorizzi, G. (2020). Venti oche e un’aquila: il sogno di Penelope. I quaderni del ramo d’oro online, 12, 179–189.
Harris, W. V. (2013). Due sono le porte dei sogni. L’esperienza onirica nel mondo antico. Pisa: Edizioni della Normale.
Jung, C. G. (1964). Man and his symbols. New York, NY: Doubleday.
Meier, C. A. (1987). Ancient incubation and modern psychotherapy. Evanston, IL: Northwestern University Press.
Puleri, A. (2020). La psicoanalisi ai tempi di Artemidoro. Freud, la cultura degli antichi, l’inventiva dei suoi predecessori. Milano: Mimesis.
Salvo, D. (2007). Sull’oniromanzia nel mondo greco e romano. Ormos, 9, 305–319.
Santi, C. (2015). Figure del sacro nell’età della crisi, II–V sec. E.v. In Maghi, sacerdoti, santi (pp. 11–18).
Sfameni Gasparro, G. (2017). Il mago e i suoi clienti: rivelazioni di saperi, epifania divina e arte magica. In Magikè téchne. Formación y consideración social del mago en el Mundo Antiguo.
Von Franz, M.-L. (1980). Dreams. Boston, MA: Shambhala Publications.
Sitografia
Saggia Sibilla. (s.d.). Oniromanzia: quello che i sogni rivelano. Recuperato da https://www.saggiasibilla.com
Significato Sogni. (s.d.). I sogni nell’antica Grecia. Recuperato da https://significatosogni.altervista.org